“Mi chiamo Daniela Di Lullo e da oggi faccio parte della collezione del MAXXI”.
Frasi di questo tipo sono apparse sulla pagina facebook di Marinella Senatore all’indomani della consegna del Premio MAXXI 2014, lo scorso giugno.
A scrivere sono alcuni tra i numerosi partecipanti alla performance che lei, in 3 settimane, ha studiato, allestito, disegnato dentro e fuori lo spazio museale, coinvolgendo chiunque fosse interessato a prendere parte al suo progetto, The School of Narrative Dance-Roma, l’ennesima tappa della nomade scuola che Marinella fa viaggiare per il mondo (Rivoli, St.Gallen, Ecuador, Svezia, Berlino) chiamando a partecipare “tutti, senza limiti di età o conoscenza”.
Dopo aver personalmente vissuto alla creazione di quest’opera (“l’unica artista partecipante al premio che il giorno dell’inaugurazione non presentava l’opera ma iniziava a farla”), partecipando alle lezioni e all’evento conclusivo, ho bloccato quest’irrefrenabile artista e le ho chiesto di raccontarsi un po’…
Il primo termine che mi viene in mente pensando ai tuoi lavori è “partecipativi”, in quanto chiedono al pubblico di essere ideatore e realizzatore dell’opera, quasi sostituendosi all’artista.
Pensi sia un termine appropriato ed esaustivo per la tua arte? Nei tuoi progetti dove va a finire l’artista e quale è il suo nuovo ruolo?
In molte circostanze hanno definito la tua arte “sociale”, quanto credi sia esatta questa qualifica per il linguaggio artistico da te prescelto?
““Partecipativo è sicuramente un termine corretto quando si parla dei miei lavori; soprattutto in The School of Narrative Dance, chiunque può apportare al progetto le sue conoscenze, i suoi saperi o semplicemente le sue curiosità; ma non parlerei di una sostituzione all’artista, piuttosto di un processo di condivisione tra persone o gruppi in cui l’artista diventa attivatore del processo stesso. Ma non si tratta solo di questo; i linguaggi messi a disposizione sono molteplici – fotografia, disegno, video, danza – e lo scopo della condivisione è soprattutto quello di costruire insieme un contenitore attivo, in cui ci sia uno scambio di energie dove le persone possono fare delle cose e non soltanto guardarle. Questo avviene grazie al coinvolgimento di intere comunità, e dunque in questo senso sì, potremmo parlare di “socialità” dell’arte, o meglio di “inclusione” spontanea del pubblico nell’arte.”
Quando penso ai tuoi lavori – How do u kill the chemist, Nui Simu, Estman Radio Drama, Rosas, Piccolo Caos – la prima cosa che colpisce sono le enormi masse di persone che coinvolgi in un lavoro corale, composto da tante professioni e capacità diverse, messe insieme – da te – per la prima volta a collaborare ad un comune progetto. Ma in ogni passaggio del lavoro, dalla sua strutturazione alla formazione della troupe, alla scelta dei docenti chiamati a condividere le loro esperienze, alla gestione delle varie anime che si vanno formando, fino ad arrivare ai prodotti artistici finali (video, film, fotografie o audio-drammi), per me non è difficile rintracciare i tuoi percorsi artistici.
Mi piacerebbe compiere un piccolo viaggio con te lungo il tuo percorso artistico, partendo da alcuni termini che, come chiavi di lettura, permettono di leggere le varie opere e aiutano ad avvicinarsi nel modo più completo alla tua ricerca.
Il primo termine è Luce.
“Penso innanzitutto a narrazione. Il mio background è variegato; c’è stata la musica, alcune esperienze straniere e poi determinante è stato il Centro Sperimentale di Cinema. Lì sono voluta andare proprio per studiare l’illuminazione e fondamentale è stato l’insegnamento con Giuseppe Rotunno (direttore della fotografia di Fellini, Visconti, Bob Fosse) grandissimo maestro a livello internazionale. L’ossessione di Rotunno era proprio “la luce racconta, la luce racconta…”: fare un piano luce su una scena vuol dire tener conto della storia, altrimenti non ha senso. Questo è un approccio unicamente suo, che va dentro la storia ed è l’aspetto al quale più istintivamente mi avvicinavo io. La luce ha un fortissimo significato narrativo ed è questo che mi ha fatto avvicinare al linguaggio cinematografico. Tutte le sue forme, dal video e dal cinema più sperimentale a quello più narrativo e classico, mi affascinano. E’ anche un grande elemento di scambio con le persone che partecipano ai miei progetti: accendere delle luci e piazzare una videocamera è un richiamo molto forte, risveglia un immaginario collettivo. Nella metodologia di lavoro che proviene dal cinema, che io adotto anche quando il prodotto finale non è un film, trovo ci sia un aspetto performativo interessantissimo. Per me è inscindibile il discorso dell’illuminazione dal suo compito di narrare, di sostenere le parole del testo, il lavoro degli attori. E lo stesso vale per la fotografia, che poi significa “scrivere con la luce”. Infondo a me interessano tutti i linguaggi –ora mi sto aprendo molto al teatro, alla drammaturgia teatrale- che credo debbano essere visti non come fine, ma come possibilità, opportunità di scambio e pretesti per avviare processi partecipativi.
All’interno della School of Narrative Dance, ma già in Rosas (opera lirica realizzata in tre paesi differenti, con oltre 20,000 persone) e in Nui Simu (realizzato con i minatori della zona di Enna) i partecipanti, lavorando con la camera e microfoni, finiscono sempre per imbattersi nella luce ed è la cosa che più li sorprende: è qualcosa di totalmente nuovo, ma non impossibile da studiare (anche con un budget piccolissimo, che di solito è quello con il quale lavoro) e, soprattutto, è avvicinabile da chiunque, una casalinga o un muratore, un giovane o un anziano. Tecniche di illuminazione diverse trasmettono esperienze narrative diverse che poi restano più che mai impresse nella memoria dello spettatore, a volte più della recitazione di un attore. Dunque, attraverso il binomio riusciamo a parlare di assetti e sistemi sociali, ottenere una narrazione che è quella della memoria storica, ma soprattutto del qui e ora; anzi proprio al momento presente sono più interessata, che in maniera naturale poi si viene a connettere con la Storia del proprio paese, senza che questo sia l’elemento centrale o di partenza.
Movimento. Aggregazione, la prima parola che mi viene in mente. Per movimento io intendo piccoli passi che chiunque può compiere. Io credo che gli artisti, al pari di altre persone creative, possano proporre piccole cose e non più di altri. L’arte partecipativa, i social engaged project, l’arte comunitaria, tutti questi termini vanno ormai molto di moda, ma restano alquanto sconosciuti e poco chiari ai più, dato che i processi all’interno di questi grandi contenitori sono tutti da sviscerare. La partecipazione è sicuramente il concetto che si associa di più al mio lavoro, è una delle tantissime risposte ad una contemporaneità che ti chiede di cambiare delle cose, di vivere l’opera d’arte in modo diverso e anche l’istituzione museale in modo nuovo. La grande adesione delle persone è il segnale che questa è la giusta direzione.
Il movimento, in senso figurato, è un piccolo spostamento che qualcuno attua: lo fa un buon insegnante nel lavoro con i suoi studenti, lo fa un ricercatore seguendo il suo progetto, l’amore e la dedizione per ogni lavoro porta a piccoli cambiamenti, micro rivoluzioni. Questi cambiamenti penso generino aggregazione: sono aggregazioni di persone, scosse inizialmente da un agente attivante. Questo credo sia il movimento.
Tecnicamente parlando, nel mio lavoro, esistono anche altri riferimenti, come quello al movimenti scenico: un movimento del proprio corpo, che i partecipanti alla School studiano sempre. Attraverso questo si recupera una memoria della propria storia, di chi si è, semplicemente muovendosi in un determinato modo in uno spazio -non danzando necessariamente- e, se fatto alla presenza di osservatori, si attiva anche una sorta di circolo di energia collettivo. Per questo nella School of Narrative Dance, più che di danza (che richiede una tecnica e una preparazione fisica) parlo di movimento scenico, in riferimento alla scena dove ci si muove, di qualsiasi dimensione sia e aperta agli osservatori.
School of Narrative Dance, avviata ormai dieci anni fa, in seguito all’opera Rosas, voleva essere una piattaforma, che parlasse di narrazione dove il movimento scenico, come la luce,il testo, la drammaturgia, la storia orale, potesse essere uno degli strumenti che le persone potevano utilizzare. Questa piattaforma, già nella sua prima esperienza (nb a Cagliari) si presentava in quanto luogo dove poter avviare delle aggregazioni che poi volendo potevano continuare un loro percorso, una volta terminato il lavoro insieme, continuando ad alimentare energie che si erano sprigionate. Questa è il lascito più importante che la School trasmette ai suoi partecipanti, ed anche per questo a breve questa piattaforma si definirà nella veste giuridica di onlus.
Incontro. Piuttosto direi inclusione, un termine al quale tengo molto e distinguo nettamente da partecipazione e collaborazione: parafrasando Maria Lind (che con Jacques Rancier, riguardo l’emancipazione dello studente e i processi di autoapprendimento, hanno influenzato molto la base teorica del mio lavoro) per “collaborazione” intendiamo il servirsi di una competenza, che può essere intercambiata; partecipare, inteso filologicamente, considera invece la parte come una cosa essenziale, significato accolto anche nei nostri progetti, in cui cambiando i partecipanti, non professionisti, apportano ognuno un pezzettino fondamentale, unico e caratterizzante il lavoro.
Io, personalmente, aggiungo qualcosa in più e parlo d’ inclusione: nella partecipazione c’è un tempo limitato in cui si fanno cose insieme, invece io credo nell’elaborazione comune dei contenuti, dove io ci sono come artista che non decide il disegno finale, ma attivo la piattaforma, modificandola ogni giorno con un personale rapporto tessuto con ogni partecipante. Più che mai nell’ultima esperienza al Maxxi, questo mio impegno è stato in ogni passaggio, dalla ricerca di contatto al suo coinvolgimento, ogni ora di ogni giorno, con tutti i mezzi di comunicazione presenti. Un po’ è proprio Roma, nella sua complessità, nelle sue difficoltà strutturali che infondo sappiamo essere anche contenutistiche- nella sua apertura al contemporaneo, che però nella pratica non riesce fino infondo, a dimostrarsi ambiente difficile dove lavorare: anche le reti di associazioni e le realtà esterne si sono rivelate sconnesse tra di loro e diffidenti nell’accettare una proposta di collaborazione.”
Ma l’inclusione avviene proprio in questo modo, inserendoci nel quotidiano delle persone, divenendo appuntamento abituale in determinati luoghi, facendo sentire chiunque partecipi “parte inclusa” non solo del progetto, ma della macchina intera dell’arte contemporanea. E’ quindi un processo di cui necessita tutto il tessuto urbano e forse il premio che ho ricevuto riflette proprio la volontà di creare oggi questo ponte, di tessere la trama di fiducia e d’informazione necessaria a far vivere l’arte contemporanea.
Il premio è stato particolarmente importante per me che all’estero lavoro da anni ed ho avuto diversi riconoscimenti dalle istituzioni straniere (nb l’ultima dal Museo Guggenheim di N.Y. che ha invitato lei come unica europea a parlare della sua pratica inclusiva e partecipativa), ma non sentivo lo stesso genere di risposta dal mio paese. Penso ora stia avvenendo un’inversione di tendenza: molti artisti e curatori decidono di restare in Italia, anche dopo una fondamentale esperienza all’estero, per cercare di portare qui la loro esperienza, lavorando anche con le Istituzioni che all’estero sono già confermate come luogo di ritrovo, incontro, divertimento per il pubblico.
Il Maxxi ha la Piazza Boetti molto frequentata, è un luogo di aggregazione e spontaneamente lì la gente ha preso parte ad alcuni incontri della School allestita esterna all’edificio, dimostrando interesse e voglia di partecipazione laddove molti non erano mai entrati neanche nel museo. Il mio augurio è che questa tendenza riesca ad invertirsi e possano varcare quella soglia.
Insegnamento. Io lo vedo vicino al termine emancipazione.
Non c’è una crew di professori che mi segue in giro per il mondo. A parte le coreografe ESPZ che sono figure fondamentali, lavorando con modalità inclusive e partecipative che riflettono la natura della School, quello che cerco di fare è di trovare membri della stessa comunità che ci accoglie interessati a condividere le loro conoscenze. Ognuno rivela una propria abilità non riconosciuta, che così viene svelata e approfondita, permettendo all’individuo di elevare la propria dignità, maturando dentro di sé nuove consapevolezze. Gli insegnanti coinvolti possono essere persone con le quali nel mio percorso ho condiviso esperienze di lavoro o di formazione, ma anche persone comuni, a volte allievi della School tornano a partecipare a nuovi progetti nel ruolo di docenti.
Corpo. Il corpo è per me la memoria e, come già dicevo prima, muovendosi la restituisce in una narrazione spontanea. Nel movimento scenico che curano le ESPZ (Elisa Zucchetti e Nandhan Molinaro) il corpo è al centro quindi è soprattutto l’espressione individuale di ognuno ad essere motore di creazione/narrazione.
Nella coreografia che i partecipanti creano alla fine del percorso sono riunite tutte le esperienze di narrazione condivise, tutti i linguaggi utilizzati fino ad allora vengono tradotti dal corpo nel suo movimento scenico. C’è un esercizio, che i partecipanti hanno fatto, di raccontare un proprio ricordo in un minuto, in 30 sec, poi in 5, poi con nessuna parola. Questa è la metafora del percorso seguito dalla School: si ascoltano per un lungo periodo tantissime voci, si conoscono tanti linguaggi -spesso apparentemente senza un nesso tra loro- poi vengono tradotti in una coreografia corale, che rifletterà le individualità dei singoli partecipanti e le condizioni esistenti in loco.
Per questo spesso penso che la School sia un po’ come una cartina tornasole di una luogo e della società che lo abita: in quanto lavora su e con l’esperienza personale e pubblica del territorio che attraversa.
Comunità. E’ indipendenza. La comunità vive finché vive il progetto. Si tratta sempre di piccoli gesti, piccole aggregazioni che, una volta terminato il lavoro insieme, potranno svilupparsi in modo indipendente e unico. Il goal non è quello di creare gruppi di lavoro, di amicizia, ma piuttosto mettere in contatto persone che trovano una motivazione e una materia di lavoro comune, anche fosse solo nella durata della School. Le intersezioni che si generano, trovandosi a sussistere per un periodo medio-lungo, spesso capita sii definiscano in maniera più forte, ma questo per me può essere solo un augurio. Non vuole esserci buonismo in questo lavoro, né esiste un atteggiamento di tipo assistenziale: quello che avviene tra queste comunità è la vita, qualcosa di inaspettato e spontaneo…che a volte torna a ricongiungersi con la School in un nuovo progetto!
Si tratta di qualcosa in più che di arte partecipata: è un nuovo modello di costruzione sociale del fare.
Francesca Campli ha una laurea in Storia e Conservazione del Patrimonio artistico e una specialistica in Arte Contemporanea con una tesi sul rapporto tra disegno e video. La sua predilizione per linguaggi artistici contemporanei abbatte i confini tra le diverse discipline, portando avanti ricerche che si legano ogni volta a precisi territori e situazioni. La passione per la comunicazione e per il continuo confronto si traducono nelle eterogenee attività che pratica, spaziando dal ruolo di critica e curatrice e quello di educatrice e mediatrice d'arte, spinta dal desiderio di avviare sinergie e confrontarsi con pubblici sempre diversi.




















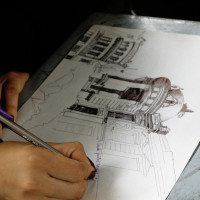















lascia una risposta