
in un ritratto fotografico di Beppe Calgaro
Era il 1993: mi trovavo a Toronto. Ero stato invitato dalla University of Toronto e dall’Ontario College of Art come visiting professor per alcune lezioni. Allora mi occupavo di Design e Comunicazione. Ero stato spesso negli USA, in Canada mai. Ero molto curioso, e tra una lezione e l’altra, amavo fare delle lunghe camminate senza meta. Lo faccio ancora oggi quando arrivo in un posto nuovo, è un mio modo per appropriarmi della città per disegnarmi una mappa personale.
In una di queste lunghe passeggiate, dove tutto avveniva in modo rigorosamente casuale, fui attratto da una piccola bottega di libri usati, mi sembra dalle parti di Bloor St. ma non ne ricordo il nome. Era molto freddo, entrai. Nella piccola stanza i rumori erano attutiti dalla moquette consumata e dagli scaffali impolverati e traboccanti di libri che arrivavano fino al soffitto. Un profumo intenso di tabacco da pipa e un filo di fumo mi guidavano in fondo al locale dove, completamente coperto dai libri, c’era il titolare che stava sorseggiando una tazza di tè. Con un filo di soddisfazione tra me e me pensai di aver beccato un posto giusto. Preso dall’euforia cominciai come un cane da tartufo a guardarmi intorno in cerca di libri strani e introvabili. Diretto verso gli scaffali di Arte e Design mi fermai prima, attratto da una cesta sul pavimento su cui c’era scritto: “50 cents each – 3 for one dollar”. Dentro, alla rinfusa, erano accatastati un centinaio di cataloghi di vecchie mostre d’arte. Cominciai a frugare alla ricerca di non so cosa… Mi capitò in mano un cataloghino in bianco e nero, molto sottile e ingiallito, di un artista mai sentito: un certo Clifford Siodmak. Sul retro, a matita, c’era scritto “$ 30”, era datato 1959. Pensai allora che era una chicca per collezionisti e che forse era finito in quella cesta per errore. Comunque iniziai a sfogliarlo e restai colpito dalle foto al suo interno. Sembrava un Bignami delle avanguardie. A parte i dipinti giovanili di un precocissimo espressionismo astratto, c’erano grossi timbri multicolor con i marchi della Coca Cola e della Lucky Strike, piccoli oggetti impacchettati con dei giornali, vari ready made, e così via. Come una mostra collettiva di alcuni grandi del ‘900 ma con opere che non avevo mai visto prima. Ma soprattutto che avrebbero dovuto essere state realizzate un bel po’ di tempo dopo da altri! Mi sembrava di essere all’interno di un episodio di “The Twilight Zone”. Con più attenzione vidi che i lavori che avrei frettolosamente attribuito a Picasso, Pollock, Rauschenberg, Warhol (solo per citarne alcuni) erano tutti suoi, e guardando ancora meglio vidi le date: tutti realizzati anche più di dieci anni prima di quelli molto famosi citati in tutti i libri di storia dell’arte. Sempre più curioso iniziai a leggere le poche informazioni presenti nel catalogo ma ancora non capivo. Chi è costui!? Il luogo della mostra era altrettanto strano: non sembrava un museo né una galleria. Dalle immagini pareva piuttosto una casa privata. E la città? Un paesino mai sentito, di cui non ricordo nemmeno il nome, sul Lago Michigan.
Al momento lo considerai una stranezza un po’ cara per le mie tasche di allora e lo rimisi al suo posto. Alla fine mi accontentai di un paio di libretti curiosi a pochi dollari e me ne andai.
Tornato a casa però, continuavo a pensare a quel cataloghino e cominciai a pentirmi di non averlo acquistato. La mattina dopo ritornai nella libreria ma non lo trovai. Deluso, chiesi al titolare (che come il giorno prima fumava e sorseggiava tè) se per caso non fosse finito in un altro scaffale o se ne avesse un altro da vendermi. Mi guardò e, sorridendomi come per approvare la mia scelta, mi disse che era l’unico che aveva e che a malincuore lo aveva venduto poco prima che io entrassi. Iniziammo a chiacchierare. Ovviamente l’argomento era Clifford Siodmak. Ero troppo curioso! Mi invitò a sedermi e mi offrì una tazza di tè lasciandomi intendere che avrebbe avuto molto da raccontare.
Mi disse che Cliff (così lo chiamava amichevolmente) lo conosceva bene: era una artista russo/ebreo/tedesco/americano di Boston che solo negli ultimi anni della sua vita si era trasferito a Toronto. Era un suo vicino di casa e tutte le mattine aveva preso l’abitudine di passare da lui a bersi un tè e a chiacchierare d’arte e letteratura. Erano diventati amici nonostante lui allora fosse giovane e Cliff ormai anziano. Mi raccontò, con un filo di commozione, che era morto alla fine degli anni sessanta per una banale indigestione – sempre stato molto goloso – aggiunse sorridendo. Era un artista eclettico. Nasceva come pittore (molto talentuoso) anche se la pittura l’aveva abbandonata e ripresa più volte, annoiandosi molto velocemente di ciò che faceva, alla ricerca in continuazione di nuove forme di linguaggio. Allora, dato che mi occupavo di Design più che di Arte, lo associai alla figura di Bruno Munari. Ma non era proprio così. Anche se continuavo a sentire che qualcosa non mi tornava (la domanda “chi era?” non mi lasciava un secondo libera la mente), più me ne parlava più mi risultava simpatico e più capivo il motivo di tante differenze, al limite della contraddizione, nella sua produzione artistica. Nello stesso tempo però vedevo anche una grande forza e coerenza estetica che legava il suo lavoro.
Possibile? Aveva anticipato moltissimi “grandi” dell’arte moderna di oltre una decina d’anni ed era come se non fosse mai esistito. Il libraio, alimentando il mio interesse, era un fiume in piena. Mi parlò a lungo delle sua vita: di origine ungherese, in fuga dalla Russia da ragazzo perché non “allineato” con la rivoluzione e poi in fuga dalla Germania nazista perché ebreo (e forse comunista) per arrivare alla fuga dagli Stati Uniti col maccartismo perché ebreo/ateo/dissidente e ancora comunista (anche se, mi diceva, non lo era mai stato davvero). In questo quadro di costante fuga mi spiegò le ragioni per cui perfino in America non riuscì mai ad essere riconosciuto per il suo valore ma anzi venne sempre ostacolato, ignorato e volutamente cancellato dall’establishment. Mi disse che non piaceva agli ebrei ma non piaceva nemmeno (forse per gli stessi motivi) ai “non ebrei”. Perfino il mondo dell’arte non lo aveva accettato. Aveva sempre teorizzato che l’arte non doveva appartenere a un mercato. Era contro le gallerie e contrario perfino alle mostre: le considerava come la morte dell’arte stessa. Non firmava mai le sue opere e se qualcuno gliene chiedeva una copia non si tirava indietro. Per lui l’arte doveva essere solo regalata e offerta; divulgata con un passaparola. Per questo le sue opere erano andate tutte dimenticate (o meglio vivevano) in case di amici e conoscenti che lo avevano amato e apprezzato finché era vivo. Mi mostrò un album di foto in bianco e nero che conservava gelosamente: quel che restava del suo lavoro. Ero a bocca aperta dallo stupore. Più tardi mi confessò di possedere anche un altra copia del cataloghino che per nulla al mondo avrebbe ceduto e un paio di opere che Cliff gli aveva regalato poco prima di morire. Mi spiegò anche che la mostra a cui si riferiva il piccolo catalogo in questione era stata l’unica. Una anomalia, un errore, una mostra casalinga, un “regalo” non gradito da parte della sorella che allora pensava di aiutarlo a guadagnare qualche dollaro, ma che invece lo mandò su tutte le furie. Era un uomo che fino all’ultimo si era sempre goduto la vita, amava molto il cibo e le belle donne e che ridicolizzava spesso gli artisti più noti raccontando su di loro aneddoti imbarazzanti che alla fine, non si sa come, risultavano puntualmente veri. Non aveva mai capito come avesse potuto essere al corrente di tutti quei retroscena. Certo ne aveva conosciuto molti personalmente. Altri invece conoscevano lui. Alcuni li stimava pure anche se questo non era sufficiente per risparmiarli dalle sue battute al vetriolo.
Mentre continuavo a sfogliare l’album, quasi sottovoce, volle precisare che molti degli amici che possedevano gelosamente i suoi lavori erano artisti famosi che lui aveva chiaramente anticipato. Mi chiesi se non ci fosse un rapporto di causa-effetto.
Mi raccontò diversi aneddoti: ad esempio quando una sera a New York in compagnia di altri artisti conobbe Peggy Guggenheim. Lei, molto attratta da lui, gli propose la sera stessa una cena a lume di candela ma lui gentilmente declinò l’invito perché doveva uscire con una bionda, Miss Bleecker St., che aveva posato per lui il giorno prima. Peggy Guggenheim non aveva gradito il suo rifiuto, potete immaginare… O quando, anni prima, a Boston bruciò nella stufa una sua scultura (un grande Golem di legno di cui vidi la foto) perché si era portato a casa una ragazza ed era inverno, faceva freddo e non aveva altro per scaldare l’appartamento. Disse che comunque il suo Golem meritava di “passare una notte all’inferno” e che lui in compenso “aveva passato una notte in paradiso”… e poi tanto nessuno avrebbe capito quella grossa statua di legno se non dopo la sua morte.
Stavamo chiacchierando ormai da quasi tre ore e mi accorsi che ero in ritardo per la lezione all’Ontario College of Art. Non potevo permettermi di arrivare tardi, salutai frettolosamente e fui fuori in un baleno.
Arrivai in aula trafelato e appena preso fiato decisi di cambiare l’argomento della lezione: iniziai improvvisando a parlare di un grande artista che si chiamava Cliff, che aveva anticipato buona parte delle avanguardie del Novecento. Provai a descrivere a parole le opere che avevo visto in foto poco prima. Non avevo nessuna immagine e nessuno aveva mai sentito parlare di lui.
Negli anni successivi cercai in vari modi di recuperare sue notizie, ma inutilmente. Nemmeno su internet: solo alcuni suoi omonimi. Nulla. Per il mondo non è mai esistito.
Nato mezzo secolo fa a Roma e morto nel futuro, non attraversa di buongrado la strada senza motivo. Impiegato prima in un forno in cui faceva arte bianca poi del terziario avanzato, da mancino dedica alle arti maggiori la sola mano sinistra. Allestisce, installa, fa deperire, dimostra, si confonde, è uno scadente imbonitore, intelligentissimo ma con l’anima piuttosto ingenua. Ha fondato in acqua gli artisti§innocenti, gruppo di artisti e gente comune, che improvvisa inutilmente operette morali. Tra suoi progetti: la Partita Bianca (incontro di calcio uguale), una partita notturna tra due squadre vestite di bianco, a cura di ViaIndustriae, Stadio di Foligno 2010 e, in versione indoor, Reload, Roma 2011 e Carnibali (per farla finita con i tagliatori di carne), Galleria Gallerati, Roma 2012.
Ha contribuito alla performance collettiva TAXXI (Movimento di corpi e mezzi al riparo dalle piogge acide contemporanee) prodotto dal Dipartimento Educazione del Maxxi nel 2012. Sua la cura del Premio città etica (per l’anno duemilae...) e del Premio Retina per le arti visive.




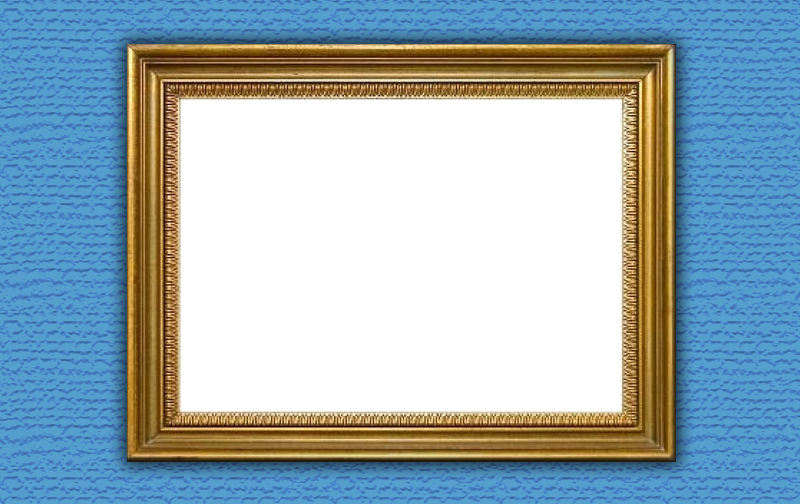





…Ma per te si! E’ esistito…e dopo una scoperta del genere ti porti a casa solo il nome?! Vogliamo avere più notizie… Quella libreria… quel libraio… E’ anche una storia bellissima per un film… Bisogna trovare quel libretto… fotografarlo… e capire! Mo’ m’hai messo la curiosità addosso … e voglio sapere come finisce ‘sta storia!
Grande Mauro!…scrivi davvero bene! Vediamoci presto così organizziamo una spedizione di ricerca. Io da NY posso iniziare a fare qualcosa? Fammi sapere? La caccia al tesoro è iniziata… ;-)
Molto interessante!
Mauro, bell’incontro, una storia nelle storie ,atmosfere, odori sapori nel tuo racconto c’è già il soggetto per un film , che dire! Franco ha ragione ……dai !
Beh, sospetto che ti sia inventato tutto. Non credo ai geni incompresi che non lasciano alcuna traccia nella storia né in internet. Poi è sospetto il nome: Clifford D. Simak è un notissimo scrittore di fantascienza, gli hai tolto il D. e hai cambiato il cognome in Siodmak, quello dei fratelli Robert e Curt (in realtà Kurt), notissimi cineasti ebrei nati a Dresda, emigrati negli USA durante il nazismo. Ne è uscito il tuo “bastardo”: Clifford Siodmak…
…mia madre ha vissuto 15 anni a Toronto e credo che l’abbia conosciuto…