Non fai in tempo a farti controllare il biglietto che ti mettono in mano una focaccella del Mulino bianco. È il segno. All’ingresso del padiglione 1 il visitatore è accolto dall’installazione tratta dal manifesto del Salone 2015: un giovane Goethe semisdraiato , in primo piano altre figure che suggeriscono l’idea di un set cinematografico: un regista, un operatore, una costumista. E poi l’effetto straniante di un cameriere con le maniche rimboccate, che spinge un carrello ricolmo di cibo. Subito dietro, enorme, fuori scala, un’utilitaria azzurra (di marca torinese, va da sé). Goethe sembra guardare distrattamente alle rovine che si intravvedono sullo sfondo. Le meraviglie d’Italia, il tema del Salone di quest’anno. La Germania, il paese ospite. La suggestione: l’Italia del Grand Tour, l’Italia vista con gli occhi dei viaggiatori cosmopoliti che, come scrive Cesare de Seta nel suo L’Italia nello specchio del Grand Tour, costruisce la sua identità culturale prima ancora di quella nazionale. Ma quale Italia?
Cibo italiano, tanto cibo, tanti libri di cibo. Effetto Expo, probabilmente. Cibo cucinato nell’ampio e sempre affollato spazio Cookbook, cibo pubblicizzato, cibo elaborato e cotto con gli strumenti degli sponsor. Autori di libri (libri?) di cucina. Chef braccati dai cacciatori di autografi. Pasticcieri all’opera in diretta nello spazio Rai. Spazio Rai nel quale campeggiano abiti che, riecheggiando Arcimboldo, sono costituiti da alimenti: ed ecco il vestito di insalata, e quello fatto di pasta (per donne da mangiare?).
L’incontro con Antonella Clerici e Benedetta Parodi si tiene nell’auditorium di Renzo Piano, capacità 2000 posti. In platea le poltrone vuote sono circa un quinto. Il pubblico è in gran parte femminile, l’età media piuttosto elevata, ma non mancano le famigliole con passeggini e papà al seguito. La Clerici arriva con un ritardo di più di mezz’ora (giustificato), e intanto la Parodi, tubino nero e tacco 15 dorato (sono le tre e mezza del pomeriggio), si intrattiene in una schermaglia pseudo-graffiante con il moderatore Luca Bianchini. In assenza dell’amica-nemica Clerici (format ben collaudato) la Parodi esordisce dicendo che lei è arrivata alla scrittura attraverso la cucina, tanto per non dimenticare i fondamentali e che siamo pur sempre al salone del libro. E mentre si lancia nell’elogio della cucina glam, quella in tacchi a spillo, dove l’importante è fare bella figura con gli ingredienti che tutti hanno a casa, fra un’ode al congelato e un’elegia funebre per gli chef spocchiosi, arriva la Clerici: il gigantesco fatturato dei libri delle due appianerebbe i debiti delle piccole case editrici in crisi. Ma, come si dice, le mele e le pere non si possono sommare. Abbandono il campo mentre mi arrivano echi di voci (Parodi) che gorgogliano le estasi indotte dal profumo caldo sprigionato dagli spaghetti rimestati nella zuppiera…
Cibo surrealista con Francesco Forlani (Il manifesto del comunista dandy). “I comunisti dandy mangiano solo bambini eleganti”, proclama fra suggestioni dadaiste e performer armati di mega megafono. In assenza di bambini, va bene anche la sacher (citazione morettiana?), decorata però con falce e martello. E mentre due cantanti del regio di Torino cantano strofe fortiniane sulle note dell’Internazionale, la sacher comunista viene porzionata e democraticamente distribuita al popolo. La maggioranza, ovviamente bulgara, applaude entusiasta.
Una delle immagini che hanno lanciato l’Expo è una rotonda mammella materna, che viene accostata alla rotondità della terra: terra-madre, madre-nutrice. Di madri parla Recalcati nel suo ultimo libro, Le mani della madre. Recalcati è solo sul palco, come un celebrante. C’è tanto silenzio, il pubblico ascolta concentrato, quasi rapito da suggestione ipnotica. Cibo, anche qui, ma per negarne la centralità. La relazione materna più pura, dice lo psicoanalista è la maternità scelta, quella adottiva, quella nella quale è assente qualunque coinvolgimento biologico. L’icona della maternità nella Bibbia è la sterile Rachele. Recalcati ribalta la retorica che focalizza il rapporto madre-figlio sul seno, da cui scaturisce l’ideologia paternalista che vede la donna fondamentalmente come nutrice (il modello Maria contro la donna-strega). Il bambino ha bisogno del cibo, ma anche di altro. Dopo la poppata, capita che il lattante guardi sgomento la madre: quello che chiede non è più nutrimento, ma altro. Chiede di essere, e può farlo solo attraverso lo sguardo della madre. Solo la madre può trasmettere al figlio quello che soddisfa fino in fondo il suo bisogno: la consapevolezza di essere desiderato. Ed ecco che il seno -spiega Recalcati- diventa “senno”: coscienza di sé, della propria individualità umana. Ogni figlio, per questo, è figlio unico: perché unicamente desiderato. Ma perché si sviluppi l’individuo, la madre deve fare un ultimo dono al figlio: quello dell’assenza. Nel gioco dell’assenza (cucù!) si forma una coscienza nuova, si compie quella rivoluzione del mondo che ogni nascita comporta.
La coscienza di Vinicio Capossela, qui per presentare Il paese di coppoloni, è Sandro Veronesi: da bravo grillo parlante, conduce Vinicio (tutti lo chiamano così, mah!) fra i meandri di una lingua e di una grammatica che aspirano a ricreare lo spirito dell’epica antica lì dove la provincia è più cupa. E aspra. E invita a camminare (“io cammino, Baricco è l’autostrada”, chiosa Vinicio) sulle strade antiche intorno all’Ofanto, il fiume di Orazio, con la lentezza del pastore, con la curiosità di Ulisse. Un autoaccredito come narratore e scrittore, una candidatura al premio Strega che esalta i fan e lascia perplessi i critici. Un romanzo mitopoietico che trasfigura la realtà rivelandone l’arcano, e permettendo di recuperare quella parte di noi avvinghiata alle radici del passato.
Recuperare senza più consumare: il Salone in realtà è l’apoteosi del consumo, culturale e non. Fra gli stand, oltre a cioccolato e popcorn, si trovano timbri e collanine, abat-jour e magliette heavy metal; selfisti, cacciatori di autografi, ragazzini che tuffano le mani sui gadget, gente improbabile col badge “stampa” o “relatore”. Il Salone pullula di gente che ti saluta anche se ti conosce appena, pronta a presentarsi con un sorriso e un “Sa, io sono uno scrittore”. Essere scrittore, soddisfare per un po’ il proprio ego, in un mondo -quello dell’editoria- in cui i titoli durano in libreria al massimo sei settimane, spesso molte di meno. Un mondo in crisi, in alcuni settori, crisi dolorosa (vedi il caso ISBN) di cui al Salone (del libro?) si è avvertita solo un’eco lontana. Un libro ha bisogno di tempo per farsi apprezzare, e a volte un successo editoriale esplode dopo molti anni dalla prima pubblicazione (in Italia, emblematico è il caso di Stoner). Che i libri su cui si è strutturata la cultura negli anni ’80 e ’90 siano ormai fuori catalogo (ma lo sono anche titoli degli anni zero e ’10) è un guasto del sistema a cui bisognerebbe porre rimedio: di questo discutono Christian Raimo (curatore della raccolta di racconti L’età della febbre) e Nicola Lagioia (La ferocia, candidato al premio Strega). Responsabili i meccanismi dell’industria editoriale, ma anche la scuola, i cui libri canonici sono arretrati di decenni. Un invito a ritornare ad una lettura lenta, dolce. Nel frattempo, negli spazi enormi del si diffondono prepotenti suoni di percussioni…
Bisogna sgusciare tra le file infinite, schivare gli incontri sold-out, per trovare qualcosa di autentico. Un’occasione per parlare di libri, un po’ meno di sé. Meritano per questo una segnalazione i due libretti curati da Paolo Nori, Repertorio dei matti della città di Milano e Repertorio dei matti della città di Bologna, frutto di un corso di scrittura ideato e seguito dallo stesso Nori. Interessante anche la forma, più simile ad un album di foto che alla struttura gerarchica di un romanzo. Nori cita in esergo Manganelli (“ho cominciato a scrivere perché non ho mai imparato ad allacciarmi le scarpe”) come esempio notevole di “matto”. Perché non si parla, qui, di patologia, pure presente, o di mera marginalità (presente anch’essa): piuttosto il matto è l’elemento inutile, l’inciampo che squilibra le nostre vite normali. [Normali? Racconta Nori: “Giravo qui fra gli stand. Mi si avvicinano due ragazze col telefonino. Mi fanno: ‘Si fa un selfie con noi?‘. Rispondo di sì, e chiedo: ‘Ma sapete chi sono?’ ‘No, ma ci piace farci dei selfie”. Ecco, queste starebbero bene in una rassegna di matti].
L’ossessione per i selfie è solo una delle tante manifestazioni del culto di sé. Così esordisce Antonio Scurati, in occasione del conferimento a Emmanuel Carrère del premio Mondello. Sala piena, pubblico meno distratto che altrove. Scurati esordisce ricordando che la gente normale fu catapultata dal divano di casa alle poltrone televisive da Maurizio Costanzo, che negli anni ’80 invitava a comparire come ospiti persone estratte sorte dall’elenco del telefono. Vediamo dunque da allora le vite degli altri proiettate, nude, in vetrina, nelle infinite vetrine che la tecnologia ci mette a disposizione. Vite degli altri che lo scrittore ha l’obbligo di farci vedere, di rendere meno opache: lo scrittore disvela il mondo, mostrando la differenza fra le vite “degli altri” e le “vite che non sono la mia”, ma che potrebbero esserlo, se i giochi fossero andati diversamente. È questa forse l’unica strada per recuperare il senso di ciò che ogni giorno scorre davanti ai nostri occhi distratti. Siamo tutti piccoli io -dice Carrère- alla disperata ricerca di un’affermazione, di un consenso, arroccati nel culto di sé: quale relazione è possibile con gli “altri io” profughi, malati, che non sono l’”altro”, ma un diverso me stesso? Occorre un mutamento prospettico, ed è questo il ruolo della letteratura.
Ed è questa la lezione di Antonio Moresco, che a Torino presenta Gli increati, il volume che conclude un percorso di ricerca trentennale. Conversando con Loredana Lipperini, Antonio Moresco esplora la possibilità che la letteratura -il romanzo- ha di segnare strade completamente nuove, ribaltando canoni e convinzioni radicate che toccano i gangli vitali della nostra esistenza umana: la vita e la morte. “La letteratura è una ferita, qualcosa che vìola ma che è anche un passaggio verso una dimensione diversa”, dice Moresco. Un terremoto che ci libera dalla paralisi della conoscenza statica, facendo di noi lettori -e uomini- finalmente redenti.
Esco dal Salone dopo due giorni, non so se redenta, certo colpita dalle contraddizioni che, qui dentro, non sono diverse da quelle che esistono fuori (“al Salone trovi le stesse persone che incontri all’Ikea la domenica”, dice un giovane uomo in coda per l’autografo di Capossela), ed è vero. Il Salone è un microcosmo che riflette l’Italia e un po’ di mondo, con alcune cose discutibili (lo stand della Massoneria è il più lussuoso, di una bellezza pacchiana e inquietante), ma anche tante cose bellissime, come i tanti ragazzi e bambini che hanno affollato a tutte le ore gli spazi a loro dedicati. Il Salone è un’occasione di incontri, un momento di festa (anche) che ognuno, come nel libro del mondo, legge scegliendosi il percorso che sente più suo.
Nasce in una piovosa notte d'ottobre, tenendo desti i genitori per quella e per molte altre notti a venire. Impara a leggere a quattro anni, e nei quaranta (e rotti) successivi non smette di farlo, anche per conto di terze persone. Si laurea con una tesi sperimentale sulla malattia d'amore. Da allora vive tentando di insegnare lingue morte a giovani teste vive ideando curiosi esperimenti (frequenti i fallimenti). Giura alla luna che non scriverà mai niente, ma è una menzogna notturna. Sta attualmente valutando cosa fare da grande.













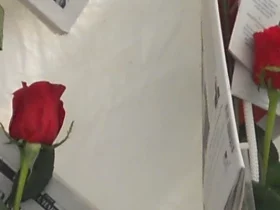


Brava. Ora so che non mi sono perso niente.