Francese, viaggiatore instancabile ed irrequieto, Gerald Bruneau è in mostra fino al 15 giugno presso la Galleria Opera Unica, a cura Takeawaygallery, con La Paolina in vetrina, scatto recente rubato durante una giornata di lavoro presso la Galleria Borghese.
Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
Conosciuto nel mondo per servizi e ritratti pubblicati sulle più importanti testate italiane e straniere, è l’assistente di Andy Warhol nella New York degli anni ’70/’80, di cui ne documenta l’atmosfera trasgressiva ed anticonvenzionale. Tra i reportage più significativi: la campagna elettorale di Jesse Jackson del 1988, le ricognizioni sul Chelsea Hotel, ed il lungo viaggio alla scoperta delle origini del Blues nel delta del Mississippi. Negli anni ’90 segue le tensioni in Israele, Kurdistan ed Albania, ritrae l’Armata Rossa e testimonia le condizioni dei condannati a morte nelle carceri del Texas. Più recenti i servizi sui niños de la calle a Città del Messico e sulla tossicodipendenza tra i giovani di New York.
Partiamo dalla Paolina, con la quale hai inaugurato il 6 giugno. Come nasce questa serie?
“Da una riflessione sul rapporto tra arte e fotografia. Baudelaire considerava la fotografia una minaccia per la pittura, e non aveva tutti i torti, ma la cosa si è rivelata diversa perché le opere ora ne hanno bisogno per la sua riproducibilità, permettendo loro di farsi conoscere. Mi interessava anche il lavoro di Christo sui monumenti, ed ho pensato quando ho visto la Paolina ad un intervento del genere, di impacchettarla. Raccontare un’opera d’arte modificandola e farmi interprete di una fantasia.”
Un salto indietro. Tu dici spesso: se sapessi raccontare una storia con le parole non avrei bisogno di trascinarmi il peso di una macchina fotografica. Quando opti per la fotografia come mezzo?
“La voglia di scoprire universi diversi, andare incontro al mondo, mi hanno spinto automaticamente verso l’immagine. All’inizio era come scattare senza macchina fotografica, nel senso di vivere avventure sempre nuove. Quando ho pensato di avere visto e conosciuto abbastanza, ho ritenuto di poter riprodurre, o comunque interpretare, con disinvoltura e libertà, coloro che incontravo, e rendere loro, con rispetto ed ironia, un omaggio.”
Scatti tanto in bianco e nero che a colori. Come scegli?
“Il colore è la vita, i sentimenti sono in bianco e nero.
E’ anche una questione di moda. L’editoria, per esempio, ad un certo momento ha scoperto il colore. Prima il giornale era in bianco e nero, poi ne viene meno la richiesta e praticamente scompare, ed è concepito quasi solo come una foto d’arte. Ma ci sono anche dei puristi, solo bianco e nero ed analogico.”
Tu però usi una macchina digitale…
“Sì, ma ha ancora un certo fascino girare con 50 rullini, sviluppare, aspettare. Con l’analogico ti spingevi molto di più perché non eri mai sicuro, non potevi soddisfarti di qualcosa che non vedevi. Ora ti contenti del necessario. Dovevi rischiare, giungere ai limiti dello sbaglio, al limite tecnico. Aiutava la creatività in un certo senso. Il vero problema del digitale però è che con esso fanno a meno dei fotografi. Ultimamente hanno licenziato 29 fotoreporter di Chicago e danno ai giornalisti l’i-phone per le immagini.
Però l’importante è saper raccontare la storia, non è scattare.”
Come nasce un servizio?
“Generalmente è il giornale che chiede di fare un lavoro, un ritratto; e la cosa è molto intrigante perché non sai mai a chi vai incontro, è sempre una novità. Ti tolgono dall’imbarazzo della scelta, talmente è vasta.
Poi ci sono serie come il Blues, che realizzo per mio conto perché sono innamorato della vicenda. Ero intrigato dai personaggi che ne hanno fatto la storia degli anni ’60 e ’70. Sono partito dalle radici lontane, l’epoca delle piantagioni di cotone, incontrando musicisti che avevano vissuto quei tempi, i figli di coloro che avevano creato tali melodie. In un servizio del genere c’è sempre la difficoltà di reperire i personaggi, perché anche se hanno fatto la storia, sono nati in una terra in cui era difficile sopravvivere.”
Reportage di guerra?
“Sì, ne ho fatti, ultimamente in Afghanistan, o in Kurdistan, ma c’è guerra un po’ dappertutto dove ci sono disuguaglianze, povertà, ricchezza distribuita in modo non proporzionato. In Sudamerica c’è un conflitto latente tra chi non ha niente e chi ha qualcosa e se lo vuole tenere, che sfocia in violenza verso i più deboli. In Messico, per esempio, sono stato sequestrato. Facevo un reportage sui ragazzi di strada, siamo andati a trovare un gruppo che viveva sotto un cavalcavia dell’autostrada, in un buco profondo 4/5 metri, e ci hanno tenuti lì dentro per qualche ora, loro sotto l’effetto di droghe, di colle. Questo dimostra quanto il pericolo si manifesti in modo inaspettato, ma è strano perché realmente la vita la rischi tanto quanto per le strade di Roma. Tutto è più o meno rischioso.”
Hai realizzato anche moltissimi ritratti….
“I linguaggi del reportage e del ritratto si sono sempre sovrapposti. Se la caratteristica del primo è nella dinamica, nel senso di essere dentro l’avvenimento, in esso ho sempre ricercato la figura umana. Così come nel secondo, dove penetro nella complessità del personaggio e la sviluppo in modo multiplo, sfruttando anche lo spazio e gli elementi che lo rappresentano.
Poi ci sono 2 scuole di ritratti, quelli in cui devi guardare in macchina, dove trasmetti qualcosa, ed adesso ci sono i giornali che vogliono lo sguardo altrove, che scimmiottano la moda anche nella vita corrente. Anche se sembra non posata, casuale, è come fare una fotografia non fotografia.”
Come è cambiato, nel tempo, il tuo mestiere?
“La mia filosofia è sempre stata che la documentazione sono le mie foto, e l’articolo le didascalie. C’era un periodo, ora sono cambiate un po’ le cose con la crisi dell’editoria, dove l’importante dentro un giornale era l’immagine. Adesso è passata in secondo piano, tende ad essere decorativa, anche il dolore deve essere accessorio perché va insieme alle pubblicità. Dunque è tutto patinato, estetico, con il lavoro di post produzione si gioca sull’esasperazione dei colori, e si cambia il clima dello scatto. Lo rendono drammatico saturandolo, scurendolo. L’immagine è diventata meno credibile, ha perso di autenticità.”
Lavori in progetto?
“Un servizio sugli ex dittatori sparsi per il mondo, quelli che sono stati destituiti. Ve ne sono ancora molti, ed alcuni fanno delle cose davvero divertenti, come avere un negozio di alimentari, o un altro finito alcolizzato e rovinato dalle donne. Li voglio fotografare per vedere come sono, chi sono, ora che non hanno più il potere.”
Carlotta Monteverde (Roma, 1981). Ha studiato Storia dell’Arte all’Università di Roma Tre. Collabora dal 2010 con la Takeawaygallery di Roma e dal 2012 con il quadrimestrale Art App. Il ritratto dell'autrice è di Rodolfo Fiorenza, Carlotta - Silenzi (dettaglio)














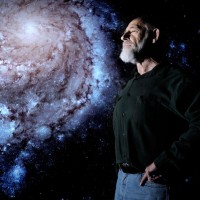







CARISSIMO BRO, INTERVISTA STUPENDA..TE NE FARO’ UNA IO IN DIRETTA..RICORDATI CHE IL PERSONAGGIO PIU’ COMPLESSO CHE HAI RITRATTO E’ IL NOSTRO THIERRY..MENTRE IL PIU’ SEMPLICE SONO IO..OLIVIER DORIA..NON SONO NESSUNO ENON LO ARO’ MAI…BACI TUO TIFOSO OLI!!!!