Non è certo da quando è uscito in tutto il mondo il suo “New Blood” che Peter Gabriel può essere considerato un papa della musica contemporanea (appellativo in qualche modo pertinente, visto anche il suo impegno umanitario anche se assolutamente laico), ma in questo momento in cui si parla soprattutto della vena intimista che lo ha condotto a rivisitare in chiave orchestrale i suoi vecchi successi, può fare uno strano effetto ritornare su quegli album classici con cui ha costruito la sua carriera solistica, album e brani che egli stesso in alcuni momenti pare abbia considerato con imbarazzo, come quando il 3 luglio 2007, tornato a Roma e precisamente a Capannelle, in occasione del RomaRock Festival, per la tournée europea del “Warm Up Tour” eseguendo dei pezzi assenti da molto tempo dalle sue scalette ma selezionate direttamente dai fan tramite il suo sito internet, spiegò: “Vogliamo spazzare via la ruggine”.
Nella vita si cambia, ma la maggior parte dei suoi fans di vecchia data, legati a lui da un affetto praticamente fraterno, non riescono ad accettare che l’animale da palcoscenico (sebbene riscattato dalla timidezza primeva) possa vagamente pensare di rinnegare parte di se stesso, ed in particolare quelle sue incarnazioni stilisticamente asciutte eppure così pregne di emotività allo stato puro e al contempo così intellettualmente stimolanti, anche sotto il profilo dell’impegno sociale, che lo resero una epitome del post-punk della prima ora, lui che aveva contribuito con i Genesis ad istituzionalizzare al massimo grado la ricchezza orchestrale del progressive sia musicalmente che con la ricerca testuale carica di riferimenti culturali, sia sotto il profilo della resa scenica, con i suoi affascinanti travestimenti teatrali! Fu appunto dopo aver prodotto il concept ed i testi dello straordinario doppio album “The lamb lies down on Broadway” che maturò la secessione dai suoi vecchi compagni di cordata, che vivevano con malcelato fastidio la popolarità personale di cui godeva sempre più Gabriel come personaggio e autore. Gabriel scrisse anche una lettera aperta alla stampa, in cui con toni semiseri illustrava le sue motivazioni alla base del distacco; ma in quei mesi maturò anche appunto una svolta stilistica iniziata proprio con il magnifico “The lamb…”, un orientamento che andava in direzione di un maggior coinvolgimento nelle tematiche sociali e in una ispirazione più metropolitana, proposta insieme alla solita positiva ansia di ricerca, ma stavolta più rivolta allo sperimentalismo sonoro e alla contaminazione, che alla creazione di atmosfere fuori dal tempo, sognanti, esoteriche ma pur sempre formalmente classicheggianti, come con i Genesis. Fu così che, dopo una cesura in cui Gabriel si dedicò ad una tranquilla esistenza di campagna nella sua residenza di Bath, “…facendo bambini e coltivando cavoli…”, come riferisce lui stesso, e cioè, verdure a parte, pensando alla famiglia, dopo il parto traumatico della prima moglie Jill, e a districarsi tra le varie idee e proposte con cui iniziare la seconda parte della sua carriera, si confermò attento a mantenere le premesse, la sua dichiarata volontà di non piegarsi alla logica affaristica del music business e cercare di percorrere quelle nuove strade a cui la sua insaziabile curiosità lo spingeva.
Il rischio era colossale, stava congedandosi dallo scenario di una sfida decennale vinta, e questo prima ancora di aver concluso le celebrazioni della vittoria. La pausa dalle scene e l’assenza di notizie però lo stavano danneggiando; molti pensarono, accettata l’onestà della sua scelta, che il suo isolamento gli stesse però sottraendo ispirazione e motivazioni. Ma infine la novità esplose: nel 1976, Gabriel volò a Toronto per registrare il suo debutto come solista, sotto lo sguardo vigile di Bob Ezrin, già produttore di Alice Cooper, Kiss e Lou Reed. Gabriel, che cercava non solo di liberarsi dall’Art Rock ma anche di affinare le sue capacità di songwriter, cercava appunto un produttore capace di confermare la sua volontà di smettere parzialmente le sue vesti di compositore europeo per lasciarsi permeare da influssi nuovi, avantguard nel senso più esplorativo del termine. Ezrin era sicuramente molto americano, e “sapeva usare uno studio meglio di chiunque altro abbia mai lavorato”, commentò Gabriel. Anche i musicisti scelti furono americani: molti furono elementi provenienti, diciamo, dall’entourage di Ezrin, eroi della chitarra heavy metal come Steve Hunter e Dick Wagner, già presenti anche in alcuni lavori di Lou Reed e Cooper, appunto, ma l’inaspettato arrivava con la partecipazione di Robert Fripp, che con quel contesto nulla aveva a che fare, ma che era, tanto quanto Peter Gabriel, interessato a calarsi in progetti al passo coi tempi, come aveva dimostrato con la mossa shock di sciogliere i suoi King Crimson per diventare, dopo un periodo di meditazione in Oriente, una “piccola unità indipendente”. Insomma il cast era “perlomeno un curioso amalgama di talenti disparati”, come fu scritto su Melody Maker.
Il dato ancora più curioso, però, e contraddittorio, in linea con la personalità di Gabriel, perennemente in bilico sul contrasto tradizione-innovazione, era che per confezionare un album che lo staccasse dal suo passato segnato dagli estetismi e dal perfezionismo baroccheggiante, Gabriel si affidasse sì ad un produttore americano, ma ad uno incline ad un’altra forma di grandiosità, quella d’una sorta di hard rock patrizio e quello della stravagante ricchezza del Lou Reed di Berlin, da Ezrin curato. Nonostante ciò, nell’insieme Peter Gabriel I, il risultato di questa interessante collaborazione è, secondo i primi commenti di Gabriel, “più semplice, emotivamente più diretto, più personale di quello che ho fatto prima, e penso che si prenda meno sul serio”. Eppure anche qui c’è da discutere: le sonorità sono più sciolte, più dirette, più americane, d’accordo, ma le composizioni restano drammatiche, espressionistiche a tratti; il linguaggio è meno ornato, eppure sembra che l’epica covi sotto le ceneri, che il fondale della visionarietà di Gabriel si sia trasferito su un’immaginario più recente, che l’artista abbia voluto misurarsi con alcune mitologie del Mondo Nuovo portandosi dietro il suo bagaglio di peculiare creatività. “Ero ansioso di comunicare le mie idee efficacemente; successe che i musicisti furono molto entusiasti del mio nuovo materiale e questo mi diede la sicurezza necessaria”.
Gabriel confidò anche che, nonostante fosse in cerca anche di una autonomia compositiva, aveva al tempo stesso avuto bisogno di un produttore come Ezrin che fosse in sintonia con lui e spingesse per produrre gran parte del materiale presentato al primo incontro, evitando all’artista inglese di sviluppare troppo le idee o introdurre complicazioni ingiustificate, forse un residuo dell’elaboratissimo processo ideativo che si realizzava democraticamente nei Genesis. L’album, comunque, viene semplicemente chiamato col nome dell’artista, che dichiarò: “Deve risultare come una sorta di informazione; non voglio dare una direzione con un titolo”, mentre la misteriosa ma moderna copertina, con l’artista appena intravedibile attraverso i vetri, bagnati dalla pioggia, di una automobile azzurra, è ad opera dello Studio Hypgnosis, e il tutto doveva fungere come il primo numero di una sorta di magazine sonoro della nascente discografia di Gabriel, una newsletter inquietante su una personalità sfuggente, un cane sciolto dell’intellighenzia musicale, non un alieno caduto sulla Terra come Bowie, con cui è degno di rivaleggiare, ma un essere umano fortemente obliquo con una identità mutante e una personalità musicale polimorfa nonché con una spiccata capacità di anticipare gli sviluppi tecnologici.
Moribund the Burgermeister è l’insolito pezzo d’apertura, che ancora è paradossalmente debitore di influenze europee: Gabriel, prima dell’inizio delle registrazioni del disco, era stato con Ezrin a Praga a seguire il celebre Magic Lantern Show, contattando i maestri burattinai locali in vista di un progetto multimediale in chiave space-rock; non se ne fece nulla, ma lui ed Ezrin se ne tornarono a casa carichi di musica folcloristica bulgara, ungherese, cecoslovacca. Questo brano bizzarro nasce appunto da suggestioni espressioniste mitteleuropee, con rimandi visuali a Bosch, un senso di sofferenza e di orrore grottesco, e con un trattamento vocale mefitico ed un ritmo che entra strusciando i piedi pesanti. Vive della contrapposizione tra il Borgomastro, simbolo di un potere che prospera occultando cose e/o demonizzando persone, e l’energia vivificatrice del “Ballo di San Vito” secondo ciò che ne aveva letto Gabriel in un testo di medicina che parlava delle epidemie del Medioevo; questo ballo, secondo la vulgata, aveva la virtù di restituire vitalità alle persone oppresse da qualche sindrome (chi viene dal Sud Italia magari saprà spiegarlo meglio…) Il testo di Gabriel è quantomai oscuro, ma nella successione dei toni vocali (come capitava in qualche pezzo dei Genesis) assume una qualità cinematografica degna del film di Wiene “Il gabinetto del dr. Caligari” e simili. Le percussioni sono sorde, le tastiere subdole, le aperture illuminano lo scenario con una luce livida.
Solsbury Hill è il singolo che in particolare fece invaghire gli USA, anche parte di quel pubblico del vasto mercato americano che non aveva mai sentito nominare questo interprete venuto dalla perfida Albione, perché si tratta di una ballad country, un folk rock in 7/4 (con la chitarra acustica in primo piano, impegnata in un fitto arpeggio che assume un ruolo ritmico) reinterpretato con un’ottica fantascientifica: un uomo semplice che forse non s’era mai sentito troppo a suo agio in questo mondo, salendo su una collina da dove si vedono le luci della città, viene in contatto con entità aliene che – paradossalmente – lo fanno sentire più se stesso che mai, il cuore batte forte ma l’Alieno è solo venuto per portarlo a casa, mentre lui ancora riflette sulle sue stantìe abitudini, su “Quale collegamento avrei dovuto tagliare” e sul camminare “dritto fuori dal meccanismo”. È chiara, al contempo, proprio per queste ed altre parole, la natura autobiografica del pezzo ed il gioco metaforico che allude alla separazione dai Genesis: “…il mio amico penserà che sono uno svitato”, canta Gabriel; sottinteso: a lasciare la gallina dalle uova d’oro.
Modern Love è uno dei pezzi più musicalmente aggressivi del disco, e anche il più diretto, quello in cui più si avverte la partecipazione del produttore e dei session men. Un rock alla Stones, è stato scritto, sicuramente ruvido anche nel testo, che sembra fare il paio con quello dell’iniziazione sessuale di Rael, il protagonista portoricano di “The Lamb…”; qui l’approccio è pesantemente primitivo ed è quasi destabilizzante immaginare anche Fripp che si prestava alla chitarra ritmica duettando con Steve Hunter come fossero “una coppia perfetta di arrabbiati rockers”, come rievoca un divertito Gabriel. Il testo è un perfetto compromesso tra l’artisticità del compositore e l’animalità istintuale del performer: pur essendo molto diretto e mirando a smentire ogni rimasuglio di pudore nei love affaires contemporanei, è tuttavia estremamente letterario, e certo non solo per i riferimenti a Lady Godiva, ad una Diana mitologica e alla Monna Lisa, tutte brutalmente attualizzate. Il cantato è un latrato stizzito che conclude le strofe in una modalità “urlata”, in una sorta di hard rock acido newyorkese.
Excuse me è il brano a sorpresa dell’album, si apre con una tonalità particolarissima di una o più voci a cappella, quanto davvero di più inaspettato ci potesse essere da parte del co-autore di “Selling England by the pound”. Anche Fripp sta al gioco: mette mano al banjo (il suo primo maestro ne era un virtuoso) mentre Tony Levin manovra il basso-tuba e intanto dirige un Barbershop Quartet, in un omaggio al dixie e al rag (e alla corrispondente fetta di storia del sound (afro)americano) tanto piacevole musicalmente quanto sarcastico, nella richiesta di un uomo alla sua donna di essere lasciato solo, con tanto di scuse di circostanza (fintissime?): “Mi stai rovinando la gioia di vivere” e “Non sono l’uomo di una volta”. Gabriel, in virtù del suo umorismo amaro e malignetto, suggerisce che il tipo non se la sia presa tanto perché la pupa ha avuto indietro i soldi e la Cadillac, ma che piuttosto sia infastidito perché costei calpesta i suoi ricordi e gli ruba da casa i souvenir! Il tutto, si badi bene, sempre messo in una forma imprevedibile.
Humdrum è uno di quei pezzi in cui si riscontrano somiglianze con le atmosfere del passato di Gabriel: dopo l’intro a base di un raffinato piano elettrico, è un tappeto di tastiere ad accompagnare la descrizione per immagini di una monotonia (humdrum) che compare e riappare in tante piccole situazioni in cui l’uomo medio si ritrova, muovendosi a scatti tra un atteggiamento e l’altro di un copione sciatto, fino all’apertura maestosa in cui finalmente si affaccia il senso primo ed ultimo di tutto l’arrabbattarsi nel piattume; un poetico surrealismo esistenziale sembra accennare all’amore e al Male in agguato, mimetizzato nella Natura e nell’anima, ma poi è il meraviglioso, l’irruzione di una forza luminosa extraterrestre che ghermisce dolcemente il narratore mentre guida nel sole, in autostrada. La metafisica è dunque presente, ma è preparata da tanti piccoli quadretti/frasi pop, quasi nello spirito di un pittore come Howard Hopper, azzardiamo.
Slowburn apre la seconda facciata (immaginandoci ancora la logica del vinile) con una nuova scarica energetica, destinata per l’arrangiamento a sorprendere ancora una volta i genesisiani più irremovibili, ma basta gettare l’orecchio oltre l’ostacolo per rendersi conto che la potenza visionaria è intatta, la magniloquenza si è solo trasferita su un diverso terreno: il tema è quello di una Apocalisse che giunga a tagliar corto con tutto quel “bruciar lento” del titolo. Il testo, stracarico e delirante nei toni profetici con cui dipinge un’umanità allo sfascio, è impreziosito da rime baciate assolutamente non prevedibili, che conferiscono al cantato, su quella base irruenta e arroventata ma con precisione clinica, un’efficacia che rende il tutto terribilmente “vero” e seducente. “Abbiamo provato con una manciata di bigliettoni e la testa piena di pasticche. Abbiamo cercato di fare film con molti fotogrammi… Cara dobbiamo credere in qualcosa, stiamo per abbattere i nostri cieli, li stiamo abbattendo”. Tutto il senso dell’imminente catastrofe aleggia e le chitarre creano un turbine, in sottofondo, che ci mangia. Le pause sembrano pneumatiche, raggelanti, ed i cori che fanno da stacchetto prima del ritornello (solo due volte) dedicato al bruciar lento del tramonto sono strida paragonabili a quelle delle arpìe.
Waiting for the Big One insiste ancora sul tema con una differente declinazione, che ha il respiro dei grandi classici jazz-blues, secondo alcuni riprendendo lo stile di Randy Newman, mentre invece Gabriel cita Mose Allison, un pianista bianco di genere blues: “il suo è un genere da piano bar, da saloon, che mi piace moltissimo”; ancora un’attitudine vicina agli standards yankee, ma anche in questo caso incisa con quel catastrofismo ultimativo che qui si manifesta con misteriosissime pause evocative, che aprono lo spazio all’inserimento dell’elemento trascendente, sotto forma di cori chiesastici o da gospel atterrito; non si sa se il Big One sia un dio punitivo o forse il terremoto che si teme un giorno spazzerà via la costa californiana. Il cantato di Gabriel è impagabile, calato nella parte del consumato beone che dopo essersi eroso la vita in angoletti in ombra, banconi, tavoli da gioco, si ritrova con un sacco di gente che si è rifugiata lì nel locale pensando di sfuggire al disastro, e a lui ormai, sia che stiano “celebrando in anticipo la fine dell’anno”, sia che stiano “aspettando il Supremo” non fa più effetto niente. A dir poco travolgente l’assolo conclusivo che si riannoda ai precedenti, quasi una liberazione, anche se simboleggia la catastrofe ormai sensibile.
Down the Dolce Vita parte con un altro strappo, di natura puramente sinfonica, ma di un’orchestra vera, non progressive, la London Symphony Orchestra, condotta dal grande Michael Gibbs, e subito dopo la drammatica overture incalza un ritmo gestito dalle due chitarre duellanti di Fripp e Hunter, in un clima da opera rock eccessiva, volutamente kitsch, forse, ma trascinante. Nelle strofe, gruppi di gente comune sembrano organizzarsi per cercare di sfuggire allo scempio, ma una voce rauca e grottesca interrompe la frenesia per dire “Voi siete proprio matti”, e giù un’altra spigolatura di sarabanda orchestrale. L’intermezzo in cui un capitano al porto scruta i volti dei fuggiaschi è pure accompagnato dall’orchestra, ma il finale è di nuovo arrembante, a rotta di collo verso il precipizio della inesorabile fine, anche se fino all’ultimo tanto attivismo patetico ci fa compagnia, e, per una mano sulla spalla, invece del pianto si smuove forse il sospetto e la diffidenza. “Cercando un modo per cavarsela”.
Here comes the Flood riporta un po’ d’equilibrio formale; sembra di vivere in un silenzio raccolto, in un’atmosfera sonora spettrale, rarefatta, gli ultimi minuti prima del maremoto che sciacquerà via tutto. La sensibilità con cui si cattura l’ultimo scorcio della Storia sembra essere quella interiore, ultimo baluardo contro il Nulla. Ci sono dei toni, come dei bip, che punteggiano l’inizio, e infatti Gabriel riferisce che quando scrisse il pezzo era ossessionato dalla radio ad onde corte, i cui segnali si facevano sempre più forti man mano che calava l’oscurità, così come “anche i livelli di energia psichica in me aumentavano di notte”. Gabriel si interessò anche di ESP, percezioni extra-sensoriali, e in un sogno vide che le barriere psichiche venivano abbattute e, dinanzi alla gran massa di pensieri altrui che ci invadevano, solo i più onesti o quelli che erano soliti esporre anche i loro pensieri più reconditi sarebbero riusciti a non annegare. In occasione dell’ideazione di questo brano in cui il calcolato cinismo lascia spazio ad una disperazione più elegiaca Gabriel sperimentò anche una di quelle situazioni in cui l’oggettività della Musica sembra condurre l’autore a scrivere proprio quelle note e non altre, dando l’impressione che il brano si componga da solo. Gabriel però successivamente si convinse che Ezrin aveva superprodotto il brano, creando un crescendo magniloquente imperniato sul lungo assolo conclusivo, mentre forse si sarebbe dovuto chiudere in chiave più meditativa, ed infatti ne esistono altre versioni. Ripetiamo: il pezzo comincia in modo raccolto e solo dopo cresce, struggente e viscerale, ed a Gabriel per un po’ piacque anche questa versione in crescendo enfatico, ma comunque Fripp si trovò d’accordo con lui sulla strabordante produzione di Ezrin, tanto da dichiarare che, anche se il progetto non era appropriato per lui, decise di rimanere per aiutare l’amico Peter, e però sul suo primo disco solista, del 1980, “Exposure”, ospitò appunto una versione alternativa, più quieta, del brano, incapsulata tra le sue Frippertronics.
Ed ancora negli ultimi concerti dal vivo di Gabriel, ogni volta che l’artista si siede da solo al piano, in acustico, ed intona quelle prime strofe, l’emozione scorre diretta da questo timido geniale istrione fino alla folla dei suoi amici/fans!
il7 - Marco Settembre, laureato cum laude in Sociologia ad indirizzo comunicazione con una tesi su cinema sperimentale e videoarte, accanto all'attività giornalistica da pubblicista (arte, musica, cinema) mantiene pervicacemente la sua dimensione da artistoide, come documentato negli anni dal suo impegno nella pittura (decennale), nella grafica pubblicitaria, nella videoarte, nella fotografia (fa parte delle scuderie della Galleria Gallerati). Nel 1997 è risultato tra i vincitori del concorso comunale L'Arte a Roma e perciò potè presentare una videoinstallazione post-apocalittica nei locali dell'ex mattatoio di Testaccio; da allora alcuni suoi video sono nell'archivio del MACRO di Via Reggio Emilia. Come scrittore, ha pubblicato il libro fotografico "Esterno, giorno" (Edilet, 2011), l'antologia avantpop "Elucubrazioni a buffo!" (Edilet, 2015) e "Ritorno A Locus Solus" (Le Edizioni del Collage di 'Patafisica, 2018). Dal 2017 è Di-Rettore del Decollàge romano di 'Patafisica. Ha pubblicato anche alcuni scritti "obliqui" nel Catalogo del Loverismo (I e II) intorno al 2011, sei racconti nell'antologia "Racconti di Traslochi ad Arte" (Associazione Traslochi ad Arte e Ilmiolibro.it, 2012), uno nell'antologia "Oltre il confine", sul tema delle migrazioni (Prospero Editore, 2019) ed un contributo saggistico su Alfred Jarry nel "13° Quaderno di 'Patafisica". È presente con un'anteprima del suo romanzo sperimentale Progetto NO all'interno del numero 7 della rivista italo-americana di cultura underground NIGHT Italia di Marco Fioramanti. Il fantascientifico, grottesco e cyberpunk Progetto NO, presentato da il7 già in diversi readings performativi e classificatosi 2° al concorso MArte Live sezione letteratura, nel 2010, è in corso di revisione; sarà un volume di più di 500 pagine. Collabora con la galleria Ospizio Giovani Artisti, presso cui ha partecipato a sei mostre esponendo ogni volta una sua opera fotografica a tema correlata all'episodio tratto dal suo Progetto NO che contestualmente legge nel suo rituale reading performativo delle 7 di sera, al vernissage della mostra. ll il7 ha quasi pronti altri due romanzi ed una nuova antologia. Ha fatto suo il motto gramsciano "pessimismo della ragione e ottimismo della volontà", ed ha un profilo da outsider discreto!









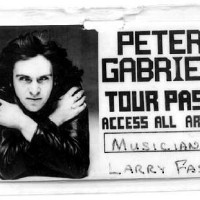

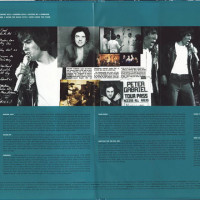






Sembre grande il sette. Kuesto albums fa bene asgoltarlo spesso. anke se si kiama car si può ascoltare in pullman o autolinee viterbesi.
ok anche non dounlodarlo illegalmente
Vorrei tranquillizzare i lettori: chi ha postato il commento precedente sembra un “Intruder” (da “Peter Gabriel III) ma in realtà è un fake (ovviamente non si chiama Peter Stuellers come dichiara) inoffensivo che ha un approccio pop italiota provinciale, vive in una cantina ingolfata di albi di Urania e ha qualche difetto di pronuncia che si porta dietro anche quando scrive. Pare però che goda di uno straordinario successo con le giovani nane.
Grazie, Gedeone. In effetti non è proprio un disco buono per ogni occasione (una grigliata sulla spiaggia di Capo Linaro, ad esempio), però soddisfa i palati fini e aiuta a canalizzare il pessimismo in ambiti limitati alla creatività. Per una discussione sulla legittimità ideale del downloading, ti rinvio a forum dedicati, sul web, dove di sicuro potrai conoscere altri soggetti virtuali “antagonisti” come te, che di tanto in tanto non risparmiano stoccate a Calderoli! Un saluto.