La prima volta che ho inteso la parola femminicidio sono rimasta perplessa, un po’ come quando sento dire assessora o ministra, parole che non fanno parte della nostra convenzione linguistica e, quindi, destabilizzano l’ordine delle cose, le nostre abitudini ed anche il nostro gusto estetico.
Il cursore diretto sulle immagini visualizzerà le didascalie; cliccare sulle stesse per ingrandire.
Perchè le parole, nonostante continuiamo ad usarle con sempre meno cognizione di causa, snaturandole ogni giorno di più dei loro significati e dei loro valori, sono comunque potenti.
Armi potentissime capaci di modificare la realtà, capaci di anestetizzare o di aizzare, capaci di dare potere a chi altrimenti non ne avrebbe alcuno e allo stesso modo di toglierlo; capaci di offrire la verità che più ci rappresenta, anche se questa è molto lontana dalla verità.
Tornando a femminicidio, non è stato difficile capirne l’origine, ma è stato (ed è ancora) davvero improbo farlo accettare alle persone e, purtroppo, anche alle donne.
Tempo addietro, in una situazione cultural-mondana, una giovane signora, istruita, moglie e mamma felice, diceva che le donne sono “migliori” degli uomini, che hanno più sensibilità, più intuito… e, insomma, tutto quell’armamentario di frasi fatte delle quali ci circondiamo ed alle quali crediamo per consolarci e fingere di avere una qualche forma di potere.
“Insomma -concluse la signora- essere donna è un privilegio!”
Mentre parlava mi passavano davanti tutti gli oltre cento femminicidi del 2011 e le ho risposto: “Ma anche no, se solo pensiamo a quante ne uccidono…”.
La reazione fu inaspettata: ” Il femminicidio è colpa delle donne che non sono in grado di capire che tipo di uomo hanno accanto o di sceglierne uno adatto.”
E invece no. Davvero no, con forza no!
E non solo no perchè dare alla vittima la colpa del proprio omicidio è un’aberrazione mentale e legale, ma soprattutto perchè una frase del genere rientra in una costruzione della realtà fatta proprio attraverso l’uso scomposto e disarticolato delle parole.
Ne parlano con passione e con molti dati alla mano Loredana Lipperini e Michela Murgia nel libro “L’ho uccisa perchè l’amavo. FALSO!” edito da Laterza nella collana Idòla.
Nel libro vengono esaminate le parole con cui si parla degli assassinii delle donne.
Le parole degli omicidi: “L’amavo più della mia vita”, “L’ho uccisa durante un lungo abbraccio”, “Ero geloso”, “E’ stato un raptus”, “Non volevo perderla” fino ad “Era depressa” o “Era malata”.
Le parole di chi racconta i fatti: televisioni, carta stampata, web, che continuando a parlare di amore, a chiamare relazione quello che è solo possesso, gelosia lo stato d’animo che provoca la perdita di possesso e amore l’impossibilità di accettare le scelte dell’altra, non fa altro che viziare il racconto, poichè, come sottolinea Michela Murgia: “Un atto narrativo legittima gli immaginari”.
E questo è: le parole vengono manipolate. In questi casi ancor più che in altri.
Dietro l’uccisione di una donna non c’è amore, ma come dicono le autrici: “una cultura che assegna loro un minor valore umano e un ruolo sociale subordinato, normalizzando la loro soppressione quando se ne discostano.”
Normalizzando e forse anche giustificandola. Oppure cercando le ragioni di questi atti nei disturbi psichici o nel mutare degli equilibri fra i generi, disarmonia che -secondo i suoi fautori- porterebbe più facilmente al tradimento, all’abbandono, alla libera scelta.
E aforza di questi richiami all’ineluttabile siamo tutti indotti a credere che l’uccisione delle donne non sia “frutto di una cultura del possesso e della sopraffazione, ma di casuali gesti singoli compiuti da soggetti labili, vulnerabili, irresponsabili…”.
“La violenza -dice sempre Michela Murgia- troppo spesso ai giorni nostri viene scambiata per conflittualità”: un altro uso improprio della parola.
La violenza contro le donne ha radici culturali molto precise, ma sono inserite talmente in profondità nel sentire collettivo che riesce a tutti noi difficile addirittura comprenderne l’esistenza. Ad esempio, parliamo facilmente di cacciatore quando ci riferiamo ad un uomo che si rapporta ad una donna: fa parte del nostro linguaggio, di quello che abbiamo imparato, ci sembra normale, ci viene finanche da sorridere e da ammiccare, sicuramente siamo lusingate se un uomo perde il controllo davanti alla nostra bellezza, perchè lo riteniamo la misura di quale sia il nostro ptoere di accendere il desiderio…
Raramente ci viene in mente che se c’è un cacciatore c’è anche una preda e la parola preda, puoi tentare di traslarla simbolicamente quanto vuoi, ma alla fine designa sempre chi viene ucciso.
Non ce ne rendiamo più conto anche perchè fa parte dei nostri concetti, addirittura delle nostre fantasie. E questo perchè tutti noi siamo allenati a pensare in una sola direzione, siamo forgiati all’interno di una letteratura (pensate a Carmen, a Turandot, a La Lupa), di una poesia popolare (quante canzonette vanno in questa direzione?) che esalta il mito di Eros e Thanatos. Amore e morte, e ci fa senza dubbio parteggiare per l’uccisore. Eroico, dannato, bello, innamorato.
Ma questa volta non è letteratura. Questa volta sono donne ammazzate perchè, improvvisamente, non rassomigliano più all’immaginario collettivo della donna sottomessa, accogliente ed in grado di contenere, ammortizzare ed appianare i conflitti e le problematiche e le lacune altrui.
Ed allora è arrivato il momento di trovare le parole giuste per parlarne.
Si dice che gli uomini che uccidono, quando poi analizzano il loro percorso, spesso dicono di non saper spiegare il loro gesto. Di non avere le parole per farlo.
Occorre dare a tutti la possibilità di averle queste parole e di saperle spendere nella maniera adeguata.
Darle in primo luogo a chi comunica, ed oggi siamo tutti comunicatori perchè tutti mandiamo mail, abbiamo blog, scriviamo su Facebook o semplicemente mandiamo sms.
Dobbiamo imparare a parlare della realtà lasciando da parte l’abitudine, lasciando le emozioni letterarie o musicali ad altri momenti e ad altri contesti. Dobbiamo concentrarci ad utilizzare un linguaggio esatto e libero da pregiudizi (come raccomanda la Federazione Internazionale dei Giornalisti), a non assimilare lo stupro ad una relazione sessuale, a raccontare tutti i fatti e non solo quelli che più ci colpiscono o più richiamano interesse, a dare informazioni e non a costruire storie.
Certo, siamo nell’era dello Storytelling, lo usano i pubblicitari e le aziende per vendere, i politici per indorarci le pillole più amare, lo usa finanche il Papa per riscattare l’immagine della Chiesa, perchè mai non dovrebbero usarlo i giornalisti per raccontare quelle atrocità che ben si prestano ad essere simbolizzate?
Proprio perchè di fronte ad una donna uccisa per abbandono e possesso c’è una sola storia da narrare: la sua. E solo dal suo punto di vista di persona. Solo usandole al meglio le parole inizieranno a recuperare il loro significato e quasi certamente aiuteranno a guardare anche ai fatti ed alla vita con strumenti diversi.
Giornalista culturale e autrice di testi ed adattamenti, si dedica da sempre alla ricerca di scritture, viaggi, tradizioni e memorie. Per dieci anni direttore responsabile del mensile "Carcere e Comunità" e co-fondatrice di "SOS Razzismo Italia", nel 1990 fonda l’Associazione Teatrale "The Way to the Indies Argillateatri". Collabora con diverse testate e si occupa di progetti non profit, educativi, teatrali, editoriali, letterari, giornalistici e web.











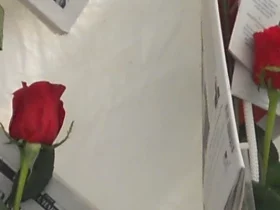


sono gesti compiuti da uomini che semplicemente non sanno, o non vogliono amare, gestire le loro sofferenze e frustrazioni e gelosie che se le sai gestire non portano al femminicidio ma se non le sai gestire è colpa tua, è colpa di chi uccide.
E l’uomo affascinato dalla bellezza femminile non c’entra proprio niente, quella è una cosa sanissima..uomini e donne si apprezzano reciprocamente da sempre
e non è detto che amore e morte ci faccia parteggiare per l’uccisore..secondo me un’opera si può interpretare in molti modi
Per poter recuperare il significato delle parole e delle parole messe insieme in composizione dovremmo ormai ricordare sempre la parola forte usata da Loredana Lipperini e Michela Murgia “FALSO”. Campanello d’allarme ad attivare il cervello sulle informazioni che ci vengono fornite… manipolate. Grazie alle autrici!
un libro difficile da leggere per tema che dramma tanto , ma utile e bello dopo che tu puoi pensare e capire . Great
Il vero problema è che dei nostri atteggiamenti e delle nostre “credenze” non ce ne rendiamo conto. E’ che siamo educati a pensare in un certo modo. E’ che i luoghi comuni hanno il sopravvento anche sui nostri desideri e non ci consentono di utilizzare altri punti di vista.
L’esercizio che dovremmo imparare è quello di guardare le cose come fossimo altro da noi. Come fossimo un cane, un migrante, una donna abusata, un bambino. Utilizzando quei sentimenti e non la nostra proiezione degli stessi… E’ un lavoro duro e sporco, un lavoro che ci mette all’angolo, ma che va bene per qualsiasi forma di intolleranza.
Non è neanche più importante sapere perchè si fanno certe cose, cosa provoca reazioni incontemìnibili. Analizzando troppo ci si mette al riparo, ci si tira fuori e invece ci siamo tutti dentro.