Del materno, molto si è scritto e in molte forme. Si può ancora dire in modo diverso? Ci provano Susanna Tartaro con La non mamma (Einaudi) e Maria Grazia Calandrone con Splendi come vita (Ponte alle Grazie) che, sintetizza Loredana Lipperini «spezzano la forma romanzo. Vanno oltre, costeggiano la poesia».
L’incontro di chiusura di Pordenonelegge, moderato con la grazia e l’acume che le è proprio dalla voce più nota della cultura di Radio 3 (un altro prezioso punto in comune tra le tre autrici che le induce a rivolgere un pensiero commosso alla collega Rossella Panarese), vede in tutti e due i testi un «viaggio nell’identità, negli oggetti, nei luoghi, che sa fuggire alla cornice. Essere altro. La ricerca di chi si è, al di là di ogni possibile casella».
Nel parlare del suo romanzo, che pure, dice «mi riguarda e mi racconta» Tartaro sfugge alla categoria dell’identità. «Non so se cerco o mi cerco in questo libro. È quello che sono». Lo sguardo di quelle donne a metà di un cammino, che non avendo figli non vi leggono proiezioni sul futuro, i cui genitori diventano figli o non ci sono più. E allora, dice, è piuttosto «un libro su quello che cerco in questo momento. Faccio i conti col fatto che il senso di maternità può averlo anche chi non ha figli», e può, come nel suo caso, nutrire in questo non una frustrazione ma un senso di «maternità diffusa» che passa, chiarisce Lipperini, attraverso la capacità di osservare e comprendere l’altro.
È questa, un’idea di maternità di grande ricerca di equilibrio col mondo e con la vita. «Chi non proietta carnalmente nel futuro, non credo che rinunci a immaginarlo», interloquisce Lipperini, e quindi nel racconto di Tartaro cerca un materno – non spasmodico, ma che si assume il compito di leggere il mondo – nel rapporto con gli altri. Inclusi gli sconosciuti, dal vicino di ombrellone in spiaggia all’ultras fuori dallo stadio.
Una riflessione, quella sul materno, che parte dal presupposto che se ne stia facendo sempre più un argomento di conversazione, di problematicizzazione. Quello che ne emerge è un ruolo di madre – ma anche la figliolanza subisce la stessa sorte – che Tartaro definisce dopato, gonfiato di quegli stereotipi che impediscono soprattutto a noi italiani una riflessione realmente articolata. Luoghi comuni che includono l’immagine di un amore perfetto, senza incrinature.
Ma, come magistralmente racconta Calandrone, l’essere madre è fatto anche di fratture, o persino di cadute del disamore, e sono più comuni di quanto si creda. Chiaroscuri che vale la pena trasformare in materia di racconto sempre più consapevole, anche per liberare dell’illusione di essere manchevole o colpevole chi li sperimenta. inendo così col percepire, se non dei vuoti, degli irrisolti.
Così come – in modo diverso – è accaduto a Calandrone che, accesa la miccia delle prime due frasi del romanzo, racconta «sentivo un debito nei confronti di una donna che mi ha amata, odiata, cresciuta, a cui non ero riuscita a dedicare nulla perché il rapporto era vero ma anche complesso. La storia della mia madre naturale – che l’ha abbandonata a otto mesi perché altri se ne prendessero cura, per poi morire, suicida, nel Tevere – mi riguarda come individuo marginalmente»
Infatti, non è in lei ma nella madre adottiva che si è consumata la frattura. L’idea che l’assenza di un legame biologico – di un vero materno, così come lei lo intendeva – la rendesse meno amabile, e che quindi la foglia l’amasse meno. La percezione difficile da raccontare, se non nella lingua raffinatissima di questa prosa passata anche per il distacco è la consapevolezza di aver visto praticato dalla madre adottiva – che, eloquentemente, si chiamava Consolazione – un grande atto d’amore contro se stessa, che ha reso la figlia consapevole di sé prima che questo potesse evolversi in forma di dolore. La frattura si crea invece, chiarisce Calandrone, sul non detto.
Cosa farne, allora, di quelle ferite? Se non sanarle, condividerle. Raccontarle con levità e con grazia, come fa Tartaro. Per frammenti e giustapposizioni, brevi lampi d’immagini sufficienti a dire mondi. Del resto, chiosa «siamo dei pezzi di quello che siamo diventati. Un insieme di cocci che la vita incolla e stacca, a volte perde. Un racconto unitario eppure fatto di frammenti, cocci di vita.
Frammenti come quelli che Calandrone ha trovato, della propria madre naturale, sulle pagine dei giornali. Che le stanno permettendo di ricostruire la vicenda di una donna sposata a forza, che dopo una vita d’inferno si era trovata una speranza in un altro uomo. Che lo aveva detto e per questo aveva subito il giudizio di un momento storico, il 1963, in cui era in vigore il reato di abbandono di tetto coniugale. Quei giornali – commenta amara Calandrone – «raccontano l’umore dell’epoca, e mi hanno fatto comprendere quanto anche a lei, sul piano letterario devo rendere qualcosa, perché la storia non è superata dai tempi. I pregiudizi che l’hanno uccisa non sono superati dai tempi. Questa estate sono stata nel paese di mia madre e non ho avuto la percezione che il sentire del paese, oggi, sarebbe diverso».
Sono entrambi, romanzi che procedono con una forma non convenzionale. Quello di Tartaro è un metodo di scrittura associativo, per sottrazione, che tratteggia bozzetti vividi ed eloquenti. Nel caso di Calandrone, invece, siamo nel dominio più schiettamente poetico, che tocca vette straordinarie di altezza lirica. Entrambi, però, a dover necessariamente trovar loro un codice, ricadono in quello del romanzo poema, il cui riferimento per Lipperini è La camera da letto di Bertolucci. Romanzi che raccontano ma senza usare la prosa.
Sotto alle parole di Calandrone, spiega l’autrice, c’è però soprattutto il Manuel Vilas di In tutto c’è stata bellezza, che ha mescolato le forme e l’ha indotta a cercare soprattutto una forma musicale che facesse ricorso a tanti espedienti della poesia.
L’altra grande prossimità – e protagonista, tutt’altro che occulta – di entrambi i romanzi è Roma. In Tartaro, anch’essa è raccontata per squarci e frammenti. «sono figlia e non mamma anche della città, e ne ho l’andamento», così come il desiderio di osservarla con lo stesso taglio di sguardo del Nanni Moretti di Caro diario, che dal suo motorino «se la fa incollare negli occhi e la restituisce su schermo». La Roma di Calandrone invece è quella degli anni Ottanta vissuti soprattutto di notte. «Roma è tremila città e tutte capaci di proporsi, con leggerezza e disincanto tutti suoi. Se ho maturato dell’ironia, è il frutto del mio essermi connaturata con le fibre della città, generosa e irritante».
Entrambi i romanzi sono, in fondo, lettere d’amore. E «la lettera d’amore è un coltello, e quando si arriva all’osso si finisce col provare una grande compassione».
Nata (nel 1994) e cresciuta in Lombardia suo malgrado, con un' anima di mare di cui il progetto del giornalismo come professione fa parte da che ha memoria. Lettrice vorace, riempitrice di taccuini compulsiva e inguaribile sognatrice, mossa dall'amore per la parola, soprattutto se è portata sulle tavole di un palcoscenico. "Minoranza di uno", per vocazione dalla parte di tutte le altre. Con una laurea in lettere in tasca e una in comunicazione ed editoria da prendere, scrivo di molte cose cercando di impararne altrettante.











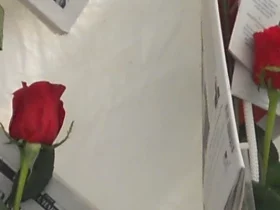


lascia una risposta