È il 27 settembre del 1960 quando il Palazzo Ducale di Venezia si anima di note insolite e sorprendenti per molti, dense di distonie e arditezze. Tanto più se si pensa che a comporle, tre secoli prima, è stata una figura che sarebbe il perfetto protagonista di un romanzo – appunto – se non fosse reale, il principe, assassino, musico: Carlo Gesualdo da Venosa.
È in questa figura ammantata di fascino e mistero che Igor Stravinskij, uno dei più grandi musicisti del nostro tempo – che su arditezze simili ha fondato la luce della sua stella – ormai anziano e nel pieno della propria fama, riconosce di aver avuto un padre, e decide di rendergli omaggio, erigendo un Monumentum.
Da questo dato storico si è mosso Andrea Tarabbia per comporre – non potrebbe esserci verbo più adatto – il suo Madrigale senza suono, edito da Bollati Boringhieri.
Un romanzo che è piuttosto un meta monumento. A Gesualdo, prima di tutto, che incarna perfettamente le figure ambigue, nere e dense di cui Tarabbia ha popolato i suoi romanzi. Attraverso un compositore barocco sconosciuto ai più, lo scrittore saronnese torna a guardare il mondo dal lato di quello che gli altri chiamano il male, sfumandone i contorni, mettendo in crisi tutte le prese di posizione, sottraendo dalle mani del lettore la possibilità di limitarsi a offrire ai suoi personaggi un sentimento quieto, di empatia o di disprezzo che sia.
Come per gli altri personaggi, Tarabbia guida, invece, a domandarsi chi è quest’uomo. Musicista di genio, principe più per forza che per vocazione della Campania dell’alba del Seicento, assassino della propria moglie per ragioni d’onore.
Grazie a questa figura, coerente con le sue precedenti, e – come e più delle altre (resa vivida da un poderoso lavoro di ricostruzione storica, per quanto l’autore dica di voler rifuggire dal romanzo storico) il Premio Campiello offre allo scrittore trapiantato a Bologna una patente e possibilità, che ormai è tra i pochi a poter garantire, anche a ragione dell’abilità a scegliere, tanto fra chi valuta quanto fra i valutati, le persone giuste, annota il presidente Zoppas.
Una legittimazione, quella del Campiello, che a Tarabbia viene dall’aver dato forma a quello che Gian Mario Villalta, accogliendolo nel tradizionale appuntamento che apre i giorni di Pordenonelegge, definisce: “Il libro di un letterato, che gioca con motivi culturali entrati nel simbolico”.
Con vanto del giurato Lorenzo Tomasin, il Campiello può dire di aver fatto, con quella di Tarabbia, una scelta coraggiosa. Nell’ambito di una giuria di qualità elevata, i giudici hanno scelto di non indulgere nei confronti dei lettori, siano essi addetti ai lavori o giurati popolari. “Si è scelto – si picca il linguista docente all’università di Losanna – di non concedere a nessuno titoli facili” e di premiare quello della cinquina che probabilmente si è rivelato “il più complesso”.
Due archi temporali e tre trame che si intrecciano. “Anche nelle pagine come nel castello – chiosa Villalta – si intrecciano più piani”. La storia del protagonista, quella di chi racconta, ovvero l’informe Gioacchino e quella di Stravinskij che punteggia con il suo sguardo la misteriosa cronaca della vita del principe arrivata a lui dalle mani del destino.
Ingredienti precisi quanto basta per dargli l’occasione di dimostrare, come commenta Villalta, una “capacità mirabile di tenere insieme molte voci in una sola partitura” e che risuona di un “raffinatissimo lavoro di stile e lingua” capace di affrontare il linguaggio di Gesualdo senza forzarlo ma senza eluderne la sfida, grazie a un narratore “capace di mettere a tassello parole desuete, un italiano corrente pur se tirato”.
Trovata la voce, l’abilità e la misura del Tarabbia direttore d’orchestra non possono che produrre così un romanzo con una struttura musicale, oltre il madrigale, verso la fuga dallo stretto finale. Una corsa sempre più serrata lungo uno spartito esistenziale che si moltiplica in riflessi, ombre e specchi della stessa persona, mentre vero e falso si scolorano l’uno dentro l’altro.
Una sonata irta di sfide: raccontare un brano musicale è una delle cose più difficili da fare. Anche se la più difficile è far ridere, la musica messa in parole rischia la retorica dei sentimenti, il tecnicismo o il racconto di pura sensazione.
All’autore, che ha portato su carta il Demone di Beslan e Andrej Cikatilo autore di 56 omicidi nella Russia degli anni Ottanta, interessava qualcosa di diverso. Torna a se stesso, e al racconto dell’orrore e del raccapriccio, ma lo fa aprendo non solo più al dilemma etico o all’empatia, ma a un interrogativo di ancora più scivoloso, perversamente affascinante: per fare cose belle bisogna avere ucciso?
Ancora una volta rovescia le aspettative del lettore, sfilandogli la risposta gustosamente più crudele e offrendogli “una contraddizione a questo assunto: in questo romanzo sono in due a creare genio, si può creare anche senza star male. Gesualdo scrive anche musica brutta: volevo sfatare la facile equazione del male che nutre il genio”.
Eppure non c’è risposta accomodante per nessuno: quel che avvince Stravinskji, il fastidio che lui stesso prova, viene anche da lì, dalla componente gotica di cui il Madrigale è ampiamente intessuto, fatto di tensione, continui sussulti. Uno apre a caso e si trova in un omicidio, poi in un’autopsia, poi in un luogo dove si porta un secchio di frattaglie e visceri a uno strano personaggio, fino al processo a una strega. Senza timore, per altro, di evitare la perfetta linearità narrativa.
Una scelta che serra i ritmi del romanzo e ne sostiene l’incalzare, ma soprattutto risponde ancora a un suono, quello della voce: “Quando si racconta si salta di palo in frasca, e scrivere non è altro che raccontare una storia a qualcuno. Io parto sempre da un qui e ora in cui qualcuno racconta qualcosa che gli è successo, che inevitabilmente ha influito su chi è diventato: per questo provo a raccontare chi è”.
E per farlo servono la materialità, la corporeità senza la quale il suono, allora, non poteva essere neppure pensato, ma anche la materialità schietta fino al disgusto della realtà. Corporea come era quel secolo, che solo una volta chiuso ci ha visto iniziare a nascondere la nostra orribilità di esseri umani dietro l’igene.
Nel Seicento di Tarabbia niente è astratto, perché tutto si tiene. Se infatti, come spiega il suo Stravinskij è così difficile far capire che non esiste una cosa totalmente nuova, vale a dire che non appoggi su qualcosa che è stato fatto prima di noi, anche quello di Tarabbia è, come per due musicisti, rimusicare quel che che c’era e farlo suo. “Dovevo confrontarmi con una serie di clichè: il principe, il castello sulla rocca, l’amante che effettivamente subisce un processo per stregoneria, un protagonista la cui vita una vita sembrava L’uomo che ride di Hugo”.
La sfida, quindi, è inevitabile: “O li annacquo facendo un torto alla memoria storica o li riutilizzo: ho provato a rivisitarli”. Le fonti storiche lo aiutano a tratteggiare figure che oggi dicono altro, e così la fedeltà alle odi esasperate che il Tasso dedicò a Maria, moglie fedifraga di Carlo assassinata con l’amante, ne tratteggiano un ritratto di femme fatale, agli occhi di oggi più vicina alla parodia di se stessa, che contribuisce a dare al questo denso romanzo una nota buffonesca e farsesca che ne fa “il mio libro con più leggerezza. Ed era una bella sfida non essere pesante dentro alle parole di Gesualdo e Stravinskij”.
Il monumentum di Tarabbia, però, è prima di tutto alla letteratura di cui si nutre, al mondo slavo che permea tutti i suoi romanzi. Così, come le note del zembalo di Gesualdo si moltiplicano in orchestra a Venezia, i tratti dei personaggi e la loro fisicità vogliono essere figlie di Memorie del sottosuolo, “delle venti pagine per restituire una spallata su cui si fonda la letteratura russa”.
E allora, in questa articolata rete di rimandi e omaggi e autoriflessioni, è forse è inevitabile tornare al Seicento, in un momento non casuale. E altrettanto lo è che questo spartito senza note passi di mano in mano come messa in narrativa di un manoscritto ritrovato, in un Seicento che Tarabbia legge come “periodo che ha ancora tante carte da giocare. E da la possibilità di tornare a una letteratura che ragiona su se stessa, sul cos’è e perché lo è”.
E in Italia confrontarsi col Seicento è farlo con i Promessi Sposi: se ragioniamo su chi siamo e dove veniamo si torna inevitabilmente lì. E a un autore ambizioso è impossibile non farsi ingolosire: “per ragionare bene su questo argomento sfido il padre di tutti”, dandogli una musica solo sua.
Nata (nel 1994) e cresciuta in Lombardia suo malgrado, con un' anima di mare di cui il progetto del giornalismo come professione fa parte da che ha memoria. Lettrice vorace, riempitrice di taccuini compulsiva e inguaribile sognatrice, mossa dall'amore per la parola, soprattutto se è portata sulle tavole di un palcoscenico. "Minoranza di uno", per vocazione dalla parte di tutte le altre. Con una laurea in lettere in tasca e una in comunicazione ed editoria da prendere, scrivo di molte cose cercando di impararne altrettante.










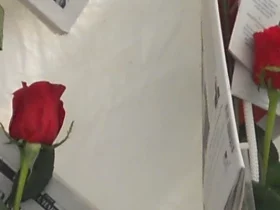


lascia una risposta